Questo è il primo di tre sguardi che si occuperanno delle feste come fenomeno sociale.
Le feste sono in genere legate ai simboli e ai significati più importanti della cultura di ogni singolo paese, volendo opportunamente trascurare quelle manifestazioni che si svolgono in modo occasionale e sono legate alle mode del momento. Dunque, le feste sono soprattutto quelle che hanno legami con la tradizione.
La ritualità è stata sempre la principale caratteristica delle feste che si sono diffuse e consolidate nella cultura popolare. Mi riferisco soprattutto agli eventi cerimoniali che hanno rilevanza in quanto riferibili ai cicli stagionali della natura, rispondendo al criterio di essere vissute nelle comunità. Il rito individua un insieme di atti o pratiche normativamente codificati e, negli studi antropologici e sociologici, permette l’affermazione dei modelli culturali di una data società con la funzione di trasmissione dei valori e delle norme, di istituzionalizzazione dei ruoli, di riconoscimento dell’identità e della coesione sociale.
In tal senso, la festa è stata sempre intesa come il periodo dedicato a riti e liturgie, ben distinti dalla vita e dal lavoro quotidiani. I fenomeni festivi hanno costituito un fatto sociale totale, allorché sono stati in grado, attraverso la loro espressione, di spiegare la struttura e la forma dei rapporti propri di una comunità: una festa popolare è la sintesi di una determinata cultura, ne riassume ed esplicita in modo esemplare tutta una serie di tratti salienti e, a partire dal folklore, continua ad essere una modalità di vivere il tempo presente.
Questo il senso della festa, così come la si intende osservando soprattutto significati e comportamenti ritualizzati, in un’accezione per così dire antropologica e legata alle tradizioni popolari, con la rappresentazione della rinascita, del cambiamento, del rinnovamento e della rigenerazione. La comunità in tal modo, celebrando una sorta di eterno presente che la privava delle dinamiche temporali, riusciva ad affermare le sue caratteristiche di unità e di consolidamento dei comportamenti tra i suoi membri. E ciò ha consolidato l’idea di realtà immodificabili e con una identità forte e definita.
Con l’avvento della società per così dire più sviluppata, negli ultimi decenni del novecento, si è avvertita la necessità di modificare l’approccio alle feste, pronosticando la fine della ritualità e ponendo la questione dell’abbandono di rappresentazioni che riconducessero a riti arcaici che non avevano ragione di esistere. Nonostante tutto, si è appreso che alcune forme ritualizzate resistevano nonostante tutto: i riti rappresentavano proprio i modi di essere e i comportamenti quotidiani di qualsiasi individuo ed in qualsivoglia società.
La concezione della festa va pertanto sempre ricondotta entro l’ambito ritualizzato e comunitario, in quanto si rappresentano attività umane significative che Mircea Eliade individuava da un lato nella funzione fisiologica e dall’altro in quella sociale, economica, culturale.
Nel nostro territorio, come altrove, i rituali più diffusi sono quelli legati alle espressioni religiose che hanno nel corso della storia condizionato molto il modo di essere cilentano, oltre che le sue tradizioni. Le comunità cilentane si caratterizzano per una profonda devozione, che si estrinseca in una religiosità popolare molto sentita e partecipata, legata essenzialmente al calendario liturgico, agli atti di fede e di preghiera, attraverso il servizio ritualizzato del culto.
In accezione comunitaria si tratta di dare vita alla tendenza a ricercare il trasporto secondo una propria tradizione locale, magari riproducendo alcuni eccessi negli atti devozionali. Quando ciò accade, il parroco cerca di limitarli ed allo stesso tempo di mantenere le espressioni genuine della pietà popolare, così come desidera la maggior parte della popolazione. In uno strano connubio tra sacro e profano, il sacro che scende al livello del popolo e lo rende partecipe dell’importanza dell’attaccamento al divino, si realizzano le manifestazioni che oggi conferiscono dignità all’aggregazione festiva e la rendono dotata di simboli e riti veramente caratteristici.
Il senso della religiosità popolare sembra naturale: molti paesi sono, per le caratteristiche architettoniche e per la loro posizione geografica, il luogo di culto per eccellenza. Sembrano vivere la presenza del Santo, subire l’influenza di quell’appartenenza al divino che regna nei vicoli, nei centri storici, nelle oscure stradine dei borghi. I luoghi e la solitudine degli stessi rimandano proprio alla presenza di un’immagine misteriosa, alla tangibilità di un’idea che qui è viva, reale. Il Santo, la Madonna sorvegliano i paesi e sembrano stendere un velo sull’esistenza statica, lenta e silenziosa.
In questo contesto, si realizza l’azione propiziatoria, ovvero fare in modo che il divino operi a nostro vantaggio, e di conseguenza acquisisce rilievo utilizzare doni o sacrifici per conformarsi alla sua volontà. Ed allora è essenziale il ricorso alle pratiche devozionali, per chiedere la protezione del Santo, attraverso culti che si manifestano in rituali eseguiti nella comunità, dunque tangibili, che si distinguono da credenze e miti che rappresentano le espressioni popolari ideali.
La preghiera è la componente essenziale di un insieme di pratiche organizzate e regolate. Essa si caratterizza per i seguenti elementi: a) un luogo e un tempo in cui compiere l’azione; b) utilizzo di una serie di parole prestabilite e di riflessioni spontanee; c) utilizzo di espressioni e comportamenti verbali e non verbali; d) utilizzo del linguaggio del corpo (gli individui stanno in ginocchio, a capo chino, con le mani giunte); e) utilizzo di oggetti (immagini, medaglie, elementi di devozione, ex voto, rosari, candele, incensi).
Uno degli aspetti essenziali della devozione è affidato alla processione, intesa come controllo istituzionale, che implica per il praticante alcune funzioni: la pratica è obbligatoria; è regolata dall’istituzione; è fissa; riguarda la comunità; è stabile e ripetuta.
In occasione di queste espressioni convivono i due elementi: rito e festa. Si realizza da un lato un “percorso formalizzato” e dall’altro il bisogno di socializzazione, di aggregazione tra gli individui.
Mazzacane ha colto alcuni elementi integrati per spiegare la festa: i comportamenti e le azioni ritualizzati e spontanei; le funzioni istituzionalizzate e quelle organizzate; i comportamenti e le funzioni riguardanti sia le forme del rituale che i rapporti sociali.
Durante le processioni è molto diffusa nel Cilento la tradizione delle cinte/cente, dedicata al perdono-voto davanti all’icona del Santo Protettore. Queste composizioni votive erano un tempo portate sul capo da donne appartenenti alla famiglia che ne aveva seguito la preparazione e affrontato l’onere economico. La persona che faceva un voto di solito portava la cinta/centa in testa ed a volte camminava scalza in segno di devozione. “Se mi fai la grazia, ti faccio la centa!”, era l’espressione più utilizzata. Tutta la gente sapeva che era stata chiesta una grazia, ma non conosceva il contenuto della richiesta.
Da riscontri tratti dalla cultura popolare, la cinta/centa si riferisce a cento candele: queste ultime, tenute assieme ed ornate da nastri colorati, assumono la conformazione di barca, di castello o di uovo, a seconda della tradizione del paese. Il termine cinto potrebbe derivare dal verbo latino: cingo > cinctum > cinto, con il valore funzionale delle candele che sono disposte intorno al telaio, per l’appunto cingendolo. Esiste anche un altro significato legato alla metafora che trova una spiegazione nella cultura greca e romana: le ragazze portavano il cinto, una fascia attorno ai fianchi, che veniva sciolta dal marito durante la notte nuziale.
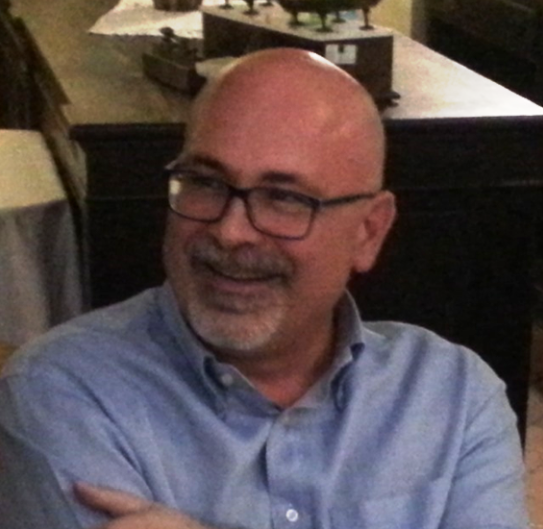

Lascia un commento