Nelle società attuali, i consumi diventano una condizione importante per rilevare come le persone costruiscono e trasmettono la propria identità sociale.
Il consumo rimanda a consumazione, consunzione, qualcosa che riguarda ciò che si logora, si usura; un processo mediante il quale i beni economici sono utilizzati e integralmente o parzialmente distrutti per appagare un bisogno “di godimento” e/o per produrre/riprodurre nuovi beni. (1)
Il successo e la centralità dei consumi rappresentano una sorta di “fenomeno magico”, che ha un “ruolo relazionale nell’ambito culturale e sociale”. È la condivisione della celebre definizione di Bauman: Consumo, dunque sono (2), che è il titolo di questo scritto. Il sociologo sosteneva che le relazioni sociali sono oggi ridefinite dal rapporto tra “consumatori e oggetti di consumo”. Per questa ragione si ricorre spesso all’espressione “società dei consumi”, resa popolare da Jean Baudrillard sottolineando il “valore/segno” che consente agli individui di collocarsi e differenziarsi all’interno di uno status sociale. (3)
Vanni Codeluppi ha analizzato i consumi del primo ventennio del duemila, dopo aver attentamente ricostruito la loro storia dalle origini e fino ai più recenti sviluppi. Si è occupato: del ruolo sociale dei consumi; delle caratteristiche che spingono le persone all’acquisto, con riferimento all’alimentazione e all’abbigliamento; della comunicazione e della pubblicità (marketing); degli usi che le persone fanno dei prodotti. Il tutto attraverso un approccio multidisciplinare che certamente tiene conto della prima scienza che ha studiato i consumi: l’economia (Smith, Ricardo, Malthus, Marx), che si è posta la questione di individuare il processo dei beni prodotti e il soddisfacimento dei bisogni degli individui. (4)
L’analisi sociologica dei consumi ha sviluppato una feconda tradizione internazionale di ricerca che, nata nell’Ottocento, è diventata negli ultimi decenni una delle più rilevanti tra quelle studiate dalle scienze sociali. Per spiegare il fenomeno, occorre fare riferimento ai comportamenti di consumo influenzati dalla famiglia, dai gruppi sociali, dagli stili di vita e dalla cultura di appartenenza. A tal fine, è importante occuparsi del funzionamento dei luoghi di consumo e il ruolo del consumatore al loro interno.
George Ritzer (5) ha studiato il mondo McDonald’s, dopo aver considerato che le società in cui viviamo pongono in primo piano il consumo e non sembrano più occuparsi di lavoro e produzione. In secondo luogo, ha rilevato come l’impatto delle tecnologie digitali sui processi di produzione e consumo determini nuove possibilità interpretative del contesto socio-culturale contemporaneo. Ritzer indica il principio di razionalizzazione e standardizzazione della gestione delle risorse umane ed economiche che la McDonald’s adotta nei suoi ristoranti: un modello efficiente, calcolabile, prevedibile e controllabile. Il processo è profondo e coinvolge gran parte delle istituzioni sociali, considerando che le società sono caratterizzate da una visione capitalista, il cui unico obiettivo è la crescente redditività. McDonald’s è il simbolo del consumo totale, globale, fruibile a tutti in qualsiasi momento e soprattutto fast; produce una condizione di standardizzazione e omologazione caratteristica della cultura di massa. Diventa essenziale l’utilizzo delle piattaforme digitali che hanno una duplice valenza: lo spazio fisico, pur non cedendo il posto a quello digitale, si fonde con esso creando soluzioni innovative.
Ritzer in precedenza aveva analizzato gli enormi centri commerciali, parchi di divertimenti, cinema multisala, impianti sportivi, che all’occorrenza si trasformano in palcoscenici di megaconcerti, spettacoli non stop, che popolano le nostre città e le nostre vite. Ponendosi l’interrogativo di come tutto ciò possa agire sulle esistenze individuali e sulla vita sociale, affermava che oggi nelle cattedrali del consumo si celebra forse l’ultimo culto (religione) del nostro tempo. (6)
I processi di consumo hanno acquisito una rilevanza centrale nel capitalismo avanzato diventando elementi di costruzione identitaria e di relazioni di potere. Per queste ragioni occorre considerare: l’influenza del sistema commerciale e lo spazio di azione dei consumatori; l’organizzazione, la riproduzione e l’innovazione delle pratiche di consumo; le giustificazioni morali ordinarie che le accompagnano. Roberta Sassatelli descrive uno scenario profondamente trasformato da internet e dagli algoritmi, dalla questione dei limiti del consumo e le conseguenze sull’ambiente e sulla sostenibilità. (7)
Le aree tematiche più significative per studiare il fenomeno riguardano: gli oggetti del consumo, ma anche il cibo, la moda e il linguaggio del corpo, il turismo e l’evoluzione dei luoghi di consumo, per giungere al rapporto tra pubblicità, marketing e new media nelle società digitali. Diventa interessante studiare il processo che si realizza tra produzione, consumo e prosumerismo (un consumatore che è produttore e nell’atto stesso del consumo contribuisce alla produzione).
Gli oggetti vengono inseriti nelle pratiche sociali come portatori di significati precisi che potrebbero riguardare le stesse dinamiche legate al concetto di dono di Mauss. L’antropologo considerava gli oggetti “mezzi di comunicazione del valore degli individui nella società”, per cui lo scambio è simbolico e riguarda sentimenti e relazioni tra le persone. Gli scambi di doni sono inseriti nella logica della cultura sociale e sono fenomeni sociali totali, in quanto sono caratterizzati da “un forte senso di obbligatorietà interindividuale”. (8)
Oggetti e loro significati diventano parti di quelle azioni che il soggetto compie sulla base delle aspettative relazionali: ovvero, la spinta all’acquisto ed al consumo avviene in modo del tutto irrazionale dal punto di vista economico, ma razionalissimo dal punto di vista sociale. Ad esempio, l’individuo può essere spinto ad acquistare oggetti per poi esibirne l’uso nei rapporti sociali, a prescindere dalle componenti di valore o di utilità.
Oggi con lo sviluppo del digitale, si sperimentano forme nuove di comunicazione. L’esempio sono i fashion movies, i filmati promozionali che vengono commissionati anche a registi famosi per promuovere le aziende. La digitalizzazione mette a disposizione uno spazio comunicativo che modifica il rapporto tra marche e consumatori un tempo monodirezionali; oggi al contrario questi ultimi sono dotati di autonomia e reagiscono formulando domande alle marche e, a volte, contestano le loro attività. Ad ogni modo, le stesse marche costruiscono relazioni con i consumatori per stabilire un “rapporto continuativo” e per definire un proprio “immaginario culturale”. Dunque, si agisce molto su quell’immaginario utilizzando icone che “diventano oggetti fortemente ammirati dalla collettività”. L’associazione è ai miti, che forniscono modelli interpretativi utili per comprendere il posto che gli individui occupano nel mondo, presentando aspirazioni che rispondono “all’identità desiderata dalle persone”. (9)
Per parlare dei luoghi del consumo si deve certamente superare la tesi di Augé, in quanto i cosiddetti non luoghi possono produrre identità al pari dei luoghi tradizionali. È vero che viene meno l’elemento della storicità e che le identità possono essere “nomadiche” (senza spazi stabili). Eppure, identità (diversamente considerate) e relazioni sono presenti anche nei centri commerciali che si trovano nelle periferie delle città e sono “importanti ambienti adatti allo svago”. Si tratta di forme di socialità di vario genere, simili a quelle che si sono manifestate negli spazi pubblici: la loro centralità è ravvisabile nei processi di integrazione che riproducono avvenimenti simili a quelli comunitari anche all’interno di cicli temporali (Natale, San Valentino, oppure i saldi invernali ed estivi). I centri commerciali sembrano offrire poi scenari magici in cui fare acquisti. Qualcuno li ha definiti: “cattedrali delle società contemporanee” (10), per il fatto che il consumatore effettua un viaggio in un luogo percepito come “forma di evasione rispetto alla dimensione della vita quotidiana”. (11)
Il consumo è stato poi oggetto di approcci critici che hanno sottolineato i danni irreversibili che essi producono all’ambiente naturale (problematica della sostenibilità). Ciò è accaduto dopo la fase di iperconsumo, abbondanza e superfluo, quando le indicazioni si concentrano su scelte di acquisto determinate da azioni e comportamenti responsabili, in cui la comunicazione ha un ruolo determinante per cercare di dare senso ad un “consumo critico” attraverso la dimensione etica.
Il consumo critico, o consapevole, responsabile, etico, intende affermare la pratica di organizzare le proprie abitudini di acquisto sulla base di criteri ambientali e sociali, accordando la propria preferenza ai prodotti che non tengono conto solo della qualità e del prezzo. In particolare, il consumatore critico considera essenziale la sostenibilità del processo produttivo e distributivo e la correttezza delle condizioni di lavoro. Questo comportamento incide sulle aziende, orientandole verso una maggiore sensibilità ecologica ed etica e perseguendo una finalità che afferma una identità civica. Si tratta di una svolta verso il cambiamento degli stili di vita aderendo ai concetti di “filiera corta”, “commercio equo e solidale”, “turismo responsabile”. (12)
In realtà, da alcuni anni si sono consolidate forme di impegno civile su scala globale. Le azioni hanno riguardato atti simbolici contro le grandi multinazionali, la partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della collettività per manifestare contro le evidenze più deleterie del consumismo. Le analisi riguardano forme di associazionismo, considerando il rapporto tra reti fiduciarie, mobilizzazione politica e costituzione dell’identità. Tutto ciò osservando le motivazioni legate alla solidarietà e alle modalità etiche del quotidiano. (13)
Oggi sono importanti analisi di tipo macro-sociale, per studiare come i significati legati agli oggetti vengono utilizzati nelle relazioni sociali; l’altra è invece più vicina al mondo della comunicazione, della pubblicità e del marketing e si occupa di comprendere come gli oggetti e i loro significati interagiscono tra loro nella creazione di sistemi di comunicazione tra gruppi e tra individui.
Si può certamente affermare che le società contemporanee tendono ad essere sempre meno caratterizzate esclusivamente dai processi produttivi e dalla struttura di classe e sempre più dalle pratiche di consumo e dagli stili di vita. In effetti, con la crescita del tempo libero, la de-politicizzazione dell’appartenenza e lo sviluppo della cultura promozionale e commerciale, le pratiche di consumo vanno ricoprendo un ruolo crescente nel sistema di vita occidentale.
Note:
- In Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/consumo/.
- Z. Bauman: Consumo, dunque sono, Laterza, 2008.
- J. Baudrillard, La società dei consumi, Il Mulino, 1976, or. 1970.
- V. Codeluppi, Il primo libro di sociologia dei consumi, Einaudi, 2024; Cfr.: V. Codeluppi, Sociologia dei consumi, Carocci, 2022.
- G. Ritzer, La McDonaldizzazione del mondo nella società dei consumi, FrancoAngeli, 2022, or. 2020.
- G. Ritzer, La religione dei consumi. Cattedrali, pellegrinaggi e riti dell’iperconsumismo, Il Mulino, 2012.
- R. Sassatelli, Consumo e teoria sociale, Il Mulino, 2024.
- V. Codeluppi, Sociologia dei consumi, cit., pp. 157-158.
- V. Codeluppi, Il primo libro di sociologia dei consumi, cit., pp. 88-99.
- G. Ritzer, La religione dei consumi, cit.
- V. Codeluppi, Il primo libro di sociologia dei consumi, cit., pp. 127-131.
- V. Russo, S. Marelli, A. Angelini, a cura di, Consumo critico, alimentazione e comunicazione, FrancoAngeli, 2016.
- L. Leonini, R. Sassatelli, a cura di, Il consumo critico, Laterza, 2008.
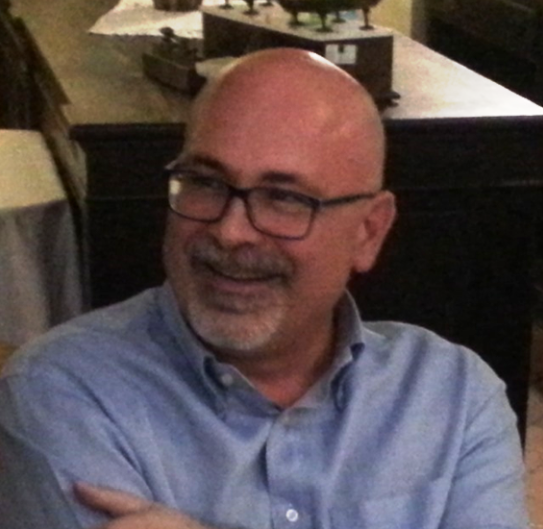

complimenti per l’approfondimento sempre più coerente delle dinamiche evolutive in una società liquida con personalità fluide e l’analisi rigorosa delle criticità
Grazie dott. Leuzzi